Cognomi arabi
I cognomi[1] arabi, turchi e persiani, come quelli di altri popoli originari del Vicino e Medio Oriente, cominciano a essere utilizzati in alcuni paesi solo verso il XVIII secolo, per influenza occidentale. La persona veniva identificata (e tuttora questo avviene in molti Paesi arabi) dal solo nome proprio di persona (ism), al quale potevano essere attribuiti vezzeggiativi in ambito familiare o amicale (ad esempio Mamadù per Muhammad). All'ism seguiva il patronimico (nasab), e il tutto si concludeva il più delle volte con l'aggiunta di epiteti circa la provenienza geografica, l'appartenenza a una scuola di pensiero (nisba) o le caratteristiche fisiche o psicologiche della persona ovvero il mestiere esercitato (laqab).
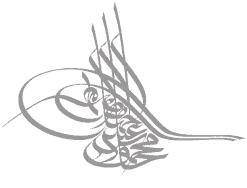
L'opinione di Giovanni Battista Rampoldi
modificaLo storico e orientalista dilettante Giovanni Battista Rampoldi scriveva all'inizio dell'Ottocento, nelle note alla sua opera "Annali Musulmani":
«Gli Arabi testimoniano il loro personale orgoglio anche nella quantità dei nomi, e questo talvolta rende molto complicato ricostruire la loro ascendenza. Questa quantità di nomi, prenomi e titoli è però necessaria per distinguersi tra di loro, stante che non hanno nomi di famiglia.[2]»
«In questo modo un arabo il quale, per esempio, abbia nome Hossein,[3] il cui padre si chiami Hashem,[4] si farà chiamare Hossein ebn[5] al Hashem[6], e se è di Mokka vi aggiungerà il nome della sua patria (città) Al Mokki, e se fosse un letterato, vi unirà pure quello della sua setta,[7] come potrebbe essere Schafei:[8] così il suo nome intero diventerà Hossein, ebn al Hashem, al Mokki, al Schafei, ed in tal modo non potrà essere confuso con un altro dei suoi compatrioti.
Nei discorsi famigliari viene talvolta indicato soltanto il nome del padre, come Ebn Hashem o Ebn Ahmed, cioè il figlio di Hashem, il figlio di Ahmed.
Talvolta per maggiormente distinguersi da un altro che possa avere lo stesso nome, si assume il nome del proprio figlio primogenito. Maometto viene anche chiamato Abu 'l Kassem, cioè il Padre di Kassem.[9]»
Rampoldi testimonia che i Turchi avessero la possibilità di farsi anche chiamare col nome della madre preceduto da Ebn (figlio di).
«Io conobbi un turco, il quale si faceva chiamare Ebn Ayesha,[10] figlio di Ayesha; domandai poi a molti maomettani, se l’uso di farsi chiamare col nome di sua madre era stabilito tra di loro, e mi venne sempre risposto, che ve n'erano taluni, ma che nessun uomo di buon senso si faceva chiamare col nome di una donna: fra gli Arabi ciò è senza esempio.
Da tutto ciò si evince che la parola araba ebn o ben, che si pronuncia ibn o bin, significa figlio, lo stesso significato di zadè in persiano ed ougli o ouglou in turco.[11]
Ebn al femminile fa bint, ed al plurale beni, banu o bueno, con parole che significano pure una famiglia, una discendenza, una tribù.
Ebn, da cui gli Ebrei e dopo i Cristiani derivarono Aven , entra talvolta fra i soprannomi arabi,[12] come la parola Abu, che significa padre; Ebn Sina è il nome del celebre Avicenna, ed Aven Rosched[13] è chiamato da noi Averroe; il primo dei Kaliffi[14] è noto sotto il nome di Abu 'l Bekr, cioè il Padre della Vergine.[15]»
Usi diversi di Ab (Abū)
modificaRampoldi scrive al riguardo:
«Si deve pure ritenere, che la sillaba o parola Ab, tanto in arabo che nell'ebreo (in ebraico), significa padre, e per metafora il padrone, il maestro, il possessore e l'inventore di qualche cosa: essa però termina diversamente secondo i casi, poiché è declinata al nominativo Abu, all'accusativo Aba, e negli altri casi Abi, il che bisogna tener presente per togliere le difficoltà che s'incontrano in molti nomi arabi.
Ab in lingua persiana significa acqua, fontana, fiume, e questa parola sovente è suffisso o prefisso nei nomi propri . Abamu, detto volgarmente Abiamu è il fiume Oxo (nome antico di Amu Darya); Nilab è il fiume Nilo dell'Indostan, poiché il fiume Nilo che scorre in Egitto si chiama anche Pengiab, (i cinque fiumi), dato che sgorga da cinque differenti sorgenti.[16][17]»
Aristocrazia
modificacontinua Rampoldi:
«Le persone di riguardo, i ministri, i generali e gli ufficiali dell'esercito, sono ordinariamente conosciuti con soprannomi magnifici, ampollosi e talvolta anche ridicoli, e che a noi sembrerebbero ingiuriosi: essi sono sempre uniti al loro nome proprio, come sarebbero: Ibrahim ebn Nouh, al Scherif,[18] cioè Abramo figlio di Noè, l'illustre; Al Ahmed, ebn Alì, al Fakih,[19] o sia Il Desiderato, figlio d’Alì,[20] il dottore;[21] taluni hanno il titolo di Malek, cioè di re nella propria scienza o arte; di Khemal, perfetto o amante della perfezione; di Khafour,[22] di Sukkar , cioè di canfora e di zucchero, che nello stile ampolloso o magniloquente degli orientali denota che le loro azioni hanno l'odore di canfora, le loro parole sono dolci come lo zucchero.[23]
Talvolta assumono il titolo di Kara,[24] il nero; Kodjea,[25] il vecchio; Semiz, il grasso o il grosso; Thawil,[26] il lungo ed anche il grande; Thopal, lo zoppo; Ahval il guercio; Dely, il pazzo, ecc.; parole che si prendono spesso nel senso di saggio, di astuto, di prudente, di coraggioso.
I principi però, sprezzando simili epiteti, preferiscono i nomi Al Kebir, Al Kanuni,[27] Al Adhel,[28] cioè il grande, il legislatore, il giusto; alcune volte sono pure chiamati Assad Al'lah,[29] il leone di Dio; Rukhno'ddin,[30] la rocca, o fortezza della religione; Emad al doulat,[31] l'appoggio o il sostegno dello Stato;[32] Dhul-riasato'ddin,[33] il possessore dei due comandi, cioè lo spirituale ed il temporale; Saddik Al’lah,[34] il testimonio di Dio. Ma alcune volte a questi enfatici titoli vengono aggiunti da un certo spirito d'indipendenza, che sovente regna fra i maomettani, gli epiteti Al Fassik,[35] Al Keavor,[36] Al Imar,[37] Al Mesth, cioè l'impudico, l'infedele, l'asino, l'ubriacone e simili.»
Inopportunità della traslitterazione in italiano
modificaA sostegno di ciò Rampoldi scrive:
«Sembrami poi opportuna cosa l'avvertire i lettori in questa prima annotazione, che in tutta quest'opera si sono conservati ai nomi arabi, persiani e turchi il loro vero ed identico suono, col quale vengono pronunciati dai nazionali; e per conseguenza si è ritenuta (conservata) la relativa ortografia. Benché questo non piacerà a tutti, nulladimeno si è creduto di non deviare da questo metodo, consultate essendosi sopra di ciò molte dotte persone, seguendo anche l'esempio di molti celebri autori, come d'Herbelot[38], Niebur[39], Savarry,[40] d'Ohson[41] ed altri, che trattarono de' fatti musulmani, stante che alcuni pochi nomi sono stati in origine trasportati nelle europee favelle, e molti di essi assai malamente. II voler dunque tradurre i nomi orientali in idioma italiano, oltre all'essere cosa impossibile, sarebbe pure voler confondere totalmente la storia.
Infatti, come mai in un’opera di questa natura si potrebbe dire un Molto desiderato, un Lodato, il Padre della vergine, il Figlio di Gesù, lo Schiavo di Dio, e simili nomi, per indicare un Ahmed, un Hamad, un Abu 'l Bekr, un Ebn Issa, un Abd Al'lah? O pure si italianizzeranno col chiamarli: Amedo, Amado, Abubecro, Avenissa, Abdallo, come taluni scrissero Ibraimo per Ibrahim, Nasulo per Nasuh, Solimano per Suleyman, che si dovrebbero propriamente tradurre Abramo, Beniamino, Salomone, che sono i veri nomi in arabo di quei patriarchi degli Ebrei, e del loro sapiente monarca.
E come tradurre i nomi di Seif al doulat, Baha'al din, Salah al din, Timur-lenk ecc., che significano: Spada dello stato, Ornamento della religione, Santo della fede, Ferro-zoppo?
Crederei quindi mancare all'oggetto per cui si scrive la storia, se, come alcuni fecero, dicessi: Seifodone Bahadino, Saladino, Timurleno o Tamerlano.
Sarebbe dunque, io lo ripeto, un voler confondere la storia e renderla totalmente oscura, se si volesse letteralmente tradurre tutti i nomi orientali, come sarebbe cosa non ben fatta il malamente tradurli.
Per convincere maggiormente il lettore, mi basti soltanto il dire che Timur-lenk tradotto per Timurleno o Tamerlano , è in verun (nessun) modo confacente ad indicare la qualità personale di questo conquistatore.
Timur è il suo vero nome, che in idioma tartaro denota ferro; l'epiteto di lenk significa zoppo: col dire Tamerlano, non si pronuncia il suo vero nome, né si indica il difetto della sua persona: da tutte le storie orientali, in qualunque idioma siano esse scritte, questo tartaro è fatto conoscere col solo nome di Timur-lenk.
Per le indicate ragioni, e per altre molte che si potrebbero addurre, i nomi propri delle persone, non che i loro titoli o soprannomi, saranno dunque conservati in quest'opera secondo l'ortografia orientale, a riserva del nome del profeta arabo, troppo facile a confondersi coi tanti altri, che portano un simil nome, cioè di Muhammed, che letteralmente significa colmo di gloria, e di alcune poche altre parole, come Kaliffo per Khalifah, Musulmano per Muslemin, il Korano per Al Koran, Egira per Hojera.
E siccome poi da taluni si tradusse Visir, Muftī, Bassà, Caimacan, Schac e simili voci, che propriamente non sono né arabe né turche né persiane, così pure si è creduto di lasciare la vera loro ortografia , che è Wazir,[42] Moufty,[43] Paschà,[44] Kaimekam,[45] Schah.[46]
Benché poi nell’alfabeto italiano non si trovi la lettera k, pure non ho saputo distogliermi dall'impiegarla nelle parole Kaʿba,[47] Korano, Kaliffo, Khan, Kairo, Kaffa, Krimea, ed in qualche altra simile, per far conoscere la loro primitiva ed originale derivazione, onde attenermi più che sia fattibile al testo arabo o ad altra lingua orientale.»
Occorre però prendere atto che nella lingua italiana moderna sono entrate a far parte comunque certe traslitterazioni come ad esempio: Cairo, Crimea, Califfo, Califfato, Corano, Visir, Musulmano, Scià, Pascià, Mufti, Averroè, Avicenna, Solimano, Saladino, Tamerlano... come tante altre testimonianze dell'influenza della dominazione araba e ottomana, o comunque dei rapporti con queste culture.
Note
modifica- ^ In questa voce il termine cognome viene utilizzato come traduzione di nasab, anche se il nasab identifica molto più precisamente di un cognome occidentale.
- ^ Giovanni Battista Rampoldi, op. cit., pp. 323-324 cap. Note del primo Volume leggi in rete Annali Musulmani - Giovanni Battista Rampoldi - Google Libri
- ^ Ḥusayn.
- ^ Ovvero Hāshim.
- ^ Ibn può essere in effetti reso come "ebn", "ben", "bin".
- ^ Che sta per "Ḥusayn ibn al-Hāshim".
- ^ In realtà quello di Muhammad ibn Idris al-Shafi'i è un madhhab, cioè una "scuola giuridica".
- ^ Appunto "al-Shafi'i".
- ^ Abū l-Qāsim è una kunya.
- ^ Ovvero "Ibn ʿĀʾisha".
- ^ La parola turca è "oğlu".
- ^ In realtà la kunya non è un soprannome ma un semplice patronimico.
- ^ Ibn Rushd.
- ^ "Califfi"
- ^ In realtà Bakr, quando non è un semplice nome proprio (come in questo caso) significa "primogenito", da cui la banale ma orgogliosa kunya di "Padre di Bakr" o "del [suo] primogenito".
- ^ Rampoldi poi specifica che i cinque fiumi alimentano un lago, dal quale originano due Pengiab: il Pengiab Mesr che scorre a nord verso l'Egitto, cioè il Nilo; (in realtà almeno due sino a Khartum: Nilo Bianco e Nilo Azzurro) e il Pengiab Soudan, cioè il Fiume dei Negri che scorre a occidente verso il al-baḥr al-Muẓallam (mare Tenebroso), cioè l'Atlantico, chiamato dagli Europei fiume Niger o Senegal (sino alle scoperte degli esploratori europei del XIX secolo che esclusero il collegamento con le fonti del Nilo).
- ^ Rampoldi, op. cit., pp. 384-385, cap. Note del terzo Volume leggi in rete Annali Musulmani, Volume 3 - Giovanni Battista Rampoldi - Google Libri
- ^ al-Sharīf.
- ^ Faqīh.
- ^ In realtà "Il lodato figlio di ʿAlī".
- ^ Nel senso di "giurisperito".
- ^ Kāfūr.
- ^ In realtà si trattava di soprannomi velati di greve ironia, in quanto assegnati in genere a schiavi, eunuchi o a omosessuali.
- ^ La parola è turca.
- ^ In lingua persiana: "Kwāja".
- ^ Arabo "tawīl".
- ^ Qānūnī (Legislatore).
- ^ al-ʿĀdil.
- ^ Asad Allāh.
- ^ Rukn al-Dīn.
- ^ ʿImād al-Dawla.
- ^ O, meglio, "della dinastia".
- ^ Dhū riyāsat al-Dīn.
- ^ Ṣādiq Allāh: "il fedele a Dio".
- ^ al-Fāsiq: "empio".
- ^ al-Kāfir.
- ^ al-Ḥimār.
- ^ Barthélemy d'Herbelot de Molainville.
- ^ Carsten Niebuhr.
- ^ François Savary de Brèves.
- ^ Ignatius Mouradgea d'Ohsson.
- ^ In realtà parola medio-persiana: vičir, "rappresentante".
- ^ Parola araba invece.
- ^ Parola turca.
- ^ Parola d'origine araba, pur se usata prevalentemente in periodo ottomano.
- ^ Parola persiana, impiegata in età achemenide e sasanide.
- ^ Kaʿba.
Bibliografia
modifica- Giovanni Battista Rampoldi, Annali Musulmani, Volume 1 (PDF), 1ª edizione, Milano, Felice Rusconi, 1822 [1822].