Ferdinando VII di Spagna
Ferdinando VII di Spagna, in spagnolo Fernando VII de Borbón (San Lorenzo de El Escorial, 14 ottobre 1784 – Madrid, 29 settembre 1833), fu re di Spagna brevemente nel 1808 e dal 1813 fino alla sua morte, e di fatto ultimo vero sovrano assoluto per diritto divino.
| Ferdinando VII di Spagna | |
|---|---|
 | |
| Re di Spagna e delle Indie | |
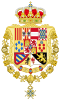 | |
| In carica | |
| Predecessore | Carlo IV (I) Giuseppe I (II) |
| Successore | Giuseppe I (I) Isabella II (II) |
| Nome completo | (ES) Fernando María Francisco de Paula Domingo Vicente Ferrer Antonio José Joaquín Pascual Diego Juan Nepomuceno Genaro Francisco Francisco Xavier Rafael Miguel Gabriel Calixto Cayetano Fausto Luis Ramón Gregorio, Lorenzo Jerónimo de Borbón[1] |
| Nascita | San Lorenzo de El Escorial, 14 ottobre 1784 |
| Morte | Madrid, 29 settembre 1833 (48 anni) |
| Luogo di sepoltura | Cripta Reale del Monastero dell'Escorial |
| Casa reale | Borbone di Spagna |
| Padre | Carlo IV di Spagna |
| Madre | Maria Luisa di Parma |
| Consorti | Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie Maria Isabella di Portogallo Maria Giuseppa di Sassonia Maria Cristina delle Due Sicilie |
| Figli | Isabella Luisa Ferdinanda |
| Religione | cattolica romana |
| Firma | 
|
Biografia modifica
Giovinezza e prima ascesa al trono modifica
Era figlio di Carlo IV e Maria Luisa di Borbone-Parma, genitori cugini.
Mal visto dal padre, Ferdinando di Borbone crebbe sviluppando un forte astio nei confronti della madre e di Manuel Godoy, primo ministro ed amante della regina. Fin da giovane, Ferdinando cospirò contro entrambi i suoi genitori regnanti e contro Godoy, incoraggiato dal suo precettore, il canonico Juan Escoiquiz. Intorno al giovane principe delle Asturie si era formato un nucleo di oppositori composto dai membri dell'alta nobiltà che desideravano la caduta di Godoy. Nel 1807 si attuò una prima cospirazione. L'ammutinamento venne scoperto e Ferdinando giudicato di conseguenza in quello che viene definito "Processo dell'Escorial". Il principe denunciò tutti i suoi collaboratori e chiese perdono ai suoi genitori. Il tribunale, per mano dei cospiratori, uomini di un certo peso politico, assolse tutti gli implicati.
Poco dopo, nel marzo 1808, in presenza delle truppe francesi in Spagna per via del trattato di Fontainebleau, la corte si trasferì nel Palazzo reale di Aranjuez, come parte di un piano di Godoy per trasferire la famiglia reale in America se ci fosse stato bisogno in caso di attacco da parte dei francesi. Il 17 marzo, il popolo, istigato dai sostenitori di Ferdinando, assalì il palazzo del Príncipe de la Paz (Godoy). Cosicché Carlo IV, per salvare la vita di Godoy, fu costretto ad abdicare a favore di suo figlio il 18 marzo. Questi fatti sono noti come la "rivolta di Aranjuez".
Abdicazioni di Bayona modifica
Ferdinando tornò alla corte, dove venne acclamato dal popolo di Madrid. Tuttavia le truppe francesi, per mano del generale Murat, avevano già occupato Madrid il giorno prima, 23 marzo. Il re deposto e la sua sposa si misero sotto la protezione di Napoleone e si rifugiarono, difesi dalle truppe di Murat. Contemporaneamente, Napoleone invitò il re Ferdinando a riunirsi a lui e il sovrano spagnolo accettò l'invito nella speranza che l'imperatore lo riconoscesse e rispettasse come re di Spagna. Benché al principio la riunione avesse dovuto svolgersi in Spagna, alla fine si tenne a Bayona. Il 20 aprile, Ferdinando passò la frontiera, del tutto ignaro che quello sarebbe stato per lui l'inizio di un esilio che sarebbe durato sei anni. Nel frattempo, Napoleone riuscì a liberare Godoy e lo fece portare a Bayona, insieme a Carlo IV e a Maria Luisa: scortato dalle truppe francesi, arrivò il 30 aprile. Intanto, a Madrid, il popolo si mosse in rivolta contro i francesi. I fatti del 2 maggio 1808 segnano l'inizio della guerra d'indipendenza spagnola.
La situazione a Bayona prese l'aspetto di un teatrino. Carlo IV dichiarò che la rinuncia al trono causata dalla rivolta di Aranjuez era nulla e pretese la restituzione dei suoi diritti. Allo stesso tempo, però, egli aveva ceduto in precedenza questi diritti a Napoleone in cambio dell'asilo politico in Francia per lui, sua moglie e il suo "prediletto" Godoy, oltre ad una ricca pensione (30 milioni di reali annui). In pratica Carlo aveva venduto la Spagna a Napoleone. Quando arrivarono a Bayona le notizie della rivolta di Madrid e della sua conseguente repressione, Napoleone ordinò a Ferdinando VII di riconoscere suo padre come sovrano legittimo. In cambio di un castello e di una pensione annuale di quattro milioni di reali, questi accettò. Così, il 5 maggio 1808, la corona di Spagna cadde nelle mani di Napoleone, il quale la cedette a suo fratello, Giuseppe Bonaparte, che avrebbe regnato in Spagna come Giuseppe I. Tutti questi complicati atti di passaggi di corone per il regno di Spagna hanno il nome di "Abdicazioni di Bayona".
Le abdicazioni di Bayona non costituirono unicamente un cambio dinastico. In un messaggio agli spagnoli, il 25 maggio, Napoleone proclamò che la Spagna si trovava di fronte a un cambio di regime, con i benefici di una costituzione senza aver avuto prima bisogno di una rivoluzione. In seguito, Napoleone convocò a Bayona un'assemblea di statisti spagnoli, la "Giunta spagnola di Bayona". Anche se la seduta fu fallimentare da un punto di vista dei partecipanti, arrivarono solo 75 dei 150 statisti previsti, in nove sessioni venne dibattuto il progetto della costituzione preparato da Napoleone e, con scarse rettifiche, approvarono nel luglio 1808 la "Costituzione di Bayona", che in realtà era uno statuto, poiché non era stato emanato da coloro che l'avrebbero diretto.
Intanto, Ferdinando vide come Napoleone non si disturbasse a rispettare l'accordo preso a Bayona, facendolo internare, insieme a suo fratello minore Carlo e suo zio paterno Antonio, nel castello di Valençay, proprietà di Talleyrand, un paese di duemila abitanti nel centro della Francia, a 300 chilometri da Parigi. Ferdinando rimase a Valençay fino alla fine della guerra d'indipendenza spagnola. Tuttavia, le sue condizioni di prigioniero politico non furono così severe. Talleyrand si lamentava del fatto che gli avevano rotto il tetto del castello a causa del gran numero di fuochi artificiali per celebrare le vittorie di Napoleone o i suoi compleanni.
Fu costretto anche a costruire una nuova sala da ballo per far fronte alla gran quantità di balli dati.
Tuttavia, la condizione di prigioniero di Napoleone creò il mito di Ferdinando il Deseado (Desiderato), vittima innocente della crudeltà napoleonica. Anche la Corte di Cadice, che redasse ed approvò la Costituzione del 1812, non discusse sulla persona del sovrano e dichiarò come unico e legittimo re della nazione spagnola Ferdinando VII di Borbone. Sempre nel 1812 Ferdinando emanò un Decreto per la creazione dell'Università di León, in Nicaragua[2]-
Ritorno del Deseado modifica
Nel luglio 1812 il futuro duca di Wellington, al comando di un esercito anglo-ispanico e penetrando dal Portogallo, batté le truppe francesi ad Arapiles, espellendoli dall'Andalusia e minacciando Madrid. Anche se i francesi contrattaccarono, ci fu una nuova ritirata dell'esercito francese dalla Spagna ai primi del 1813. Ciò permise alle truppe alleate di cacciare definitivamente Giuseppe Bonaparte da Madrid e sconfiggere definitivamente i francesi nelle battaglie Vitoria e San Marcial. Giuseppe I lasciò il paese. Napoleone si apprestò a difendere la sua frontiera meridionale, aspettando di poter negoziare con Ferdinando VII un'uscita, che si concretizzerà in un trattato di pace.
In cambio della sua neutralità in ciò che restava della guerra, Ferdinando VII recuperò la sua corona ai primi del 1814 e accordò la pace con la Francia. Acconsentì anche il perdono per i seguaci spagnoli di Giuseppe I: los afrancesados. Questo accordo è noto come trattato di Valençay, l'11 novembre 1813. Anche se il trattato era già ratificato, Ferdinando VII venne liberato e rientrò in Spagna solo nel marzo 1814: passò la frontiera il 24 marzo.
Ferdinando VII e la Costituzione del 1812 modifica
Secondo i decreti della corte « [...] non si riconoscerà per libero il re, né per tanto, gli si presterà obbedienza finché [...] non presti giuramento all'articolo 173 della Costituzione». Ferdinando VII, tuttavia, si rifiutò di ottemperare agli accordi sottoscritti dalla reggenza ed entrò a Valencia il 16 aprile. Lì lo aspettavano due persone: un rappresentante della reggenza, con il testo della Costituzione del 1812, ed un deputato assolutista, con un manifesto assolutista firmato da 69 deputati e chiamato Manifesto dei persiani. Il 17 aprile, il generale Francisco Javier de Elío invitò il monarca a difendere i propri diritti, mettendo le sue truppe a disposizione del sovrano e realizzando quello che può essere considerato il primo dei molti "pronunciamenti", che affliggeranno la Spagna per i successivi 124 anni, fino allo scoppio della guerra civile.
Il 4 maggio 1814, Ferdinando VII, particolarmente duro e vendicativo, ferocemente reazionario, promulgò un decreto che dichiarava nulla e senza alcun effetto tutta l'opera della Corte di Cadice (« [...] [erano] quella Costituzione e quei decreti nulli e di nessun valore né effetto, adesso e senza tempo alcuno, come si non fossero mai passati tali atti e restassero in mezzo al tempo»). Il 5 maggio, Ferdinando VII uscì da Valencia e cominciò una marcia trionfale verso Madrid. L'entusiasmo popolare di fronte al ritorno di el Deseado era immenso. Il regime costituzionale non fu capace di opporre alcuna resistenza: le Camere vennero sciolte il 10 maggio 1814.
Regno di Ferdinando VII modifica
Durante la prima tappa del regno, tra gli anni 1814 e 1820, il re ristabilì il precedente assolutismo per diritto divino del padre, seguendo lo stile della restaurazione borbonica attuata in Francia. Fu un periodo di persecuzione per il liberalismo, i cui sostenitori tentarono di sollevare rivolte varie volte per ristabilire la Costituzione. Da un altro lato, nonostante Ferdinando VII avesse promesso di rispettare gli afrancesados, incominciò invece ad esiliare tutti coloro che avevano partecipato al governo di Giuseppe I.
Durante questo periodo, scomparvero la totalità dei giornali, i municipi costituzionali e le università, e si ristabilì l'organizzazione per corporazioni.
Durante il gennaio 1820 ci fu una rivolta tra le forze militari che dovevano partire per l'America per difendere le colonie in mano alla Spagna. Benché questo pronunciamento, comandato da Rafael del Riego, non ebbe abbastanza successo, il governo nemmeno fu capace di soffocarlo e poco tempo dopo una nuova sommossa iniziò in Galizia e si estese per tutta la Spagna. Ferdinando VII, non potendo resistere, si vide obbligato a fare un giuramento sulla Costituzione di Cadice, a Madrid, il 10 marzo 1820. Iniziò così il Triennio liberale spagnolo, altrimenti noto come "Triennio costituzionale".
Tuttavia, nonostante il re mostrasse di applicare il regime costituzionale, in realtà aveva sempre simulato tutto e cospirava segretamente per ristabilire l'assolutismo: Regencia de Urgel; sommossa della Guardia Real nel luglio 1822, soffocata dalla Milicia Urbana di Madrid. Infine, l'intervento dell'esercito francese dei "Centomila Figli di San Luigi", sotto il controllo della Santa Alleanza, ristabilì la monarchia assoluta in Spagna nell'ottobre 1823. Furono eliminati tutti i cambiamenti del triennio liberale, con l'unica eccezione dell'Inquisizione. Il 13 gennaio 1824 con un Regio decreto, durante il Decennio nefasto spagnolo, istituì la Superintendencia General de Policía, primo corpo di polizia sorto in Spagna.
Matrimoni di Ferdinando VII modifica
Ferdinando VII si sposò più volte. Il 4 ottobre del 1802 vennero celebrate le nozze con Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie, sua cugina di primo grado, esponente del ramo dei Borbone di Napoli. Il matrimonio aveva una forte connotazione politica, in quanto volto a rafforzare i legami tra la Spagna e i regni italiani retti dai Borbone. Nello stesso periodo venne inoltre celebrato il matrimonio tra Maria Isabella di Borbone-Spagna, sorella di Ferdinando e Francesco I delle Due Sicilie, fratello di Maria Antonia e principe ereditario del Regno delle Due Sicilie. Il matrimonio tra Maria Antonia e Ferdinando tuttavia non produsse discendenza e Maria Antonia morì di tubercolosi il 21 maggio 1806. Rimasto vedovo, Ferdinando sposò nel 1816 una nipote, Maria Isabella di Braganza. Questo secondo matrimonio ebbe breve durata, in quanto Maria Isabella morì nel 1818 in seguito alle complicazioni di un parto. Da questo secondo matrimonio nacque una figlia, María Isabel Luisa, che tuttavia sarebbe morta dopo pochi mesi. Nel 1819 il re vedovo sposò Maria Giuseppa Amalia di Sassonia, sua cugina di secondo grado, senza avere figli neanche da lei. Nel 1829, si unì infine in matrimonio per la quarta volta, con un'altra sua nipote, Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie. Da questo ultimo matrimonio sarebbero nate due figlie, ovvero Isabella, futura regina di Spagna, e Luisa Ferdinanda di Borbone-Spagna.
Il 31 marzo 1830, Ferdinando promulgò la Prammatica Sanzione (Pragmática Sanción), approvata il 30 settembre 1789, al tempo di Carlo IV, che non era stata seguita per ragioni di politica estera. La Pragmática stabiliva che, se il re non avesse avuto un erede maschio, la figlia maggiore avrebbe ereditato il trono. Questo escludeva, in pratica, l'infante don Carlo Maria Isidoro dalla successione: per quanto fosse bambino o bambina colui che fosse nato, sarebbe stato di diritto l'erede del re. In questo modo, sua figlia Isabella (la futura Isabella II), nata poco dopo, si vedeva riconosciuta come erede della corona, con grande disapprovazione dei sostenitori dell'infante Carlo Maria Isidoro, il fratello minore del re. Luis de Mon y Velasco (1826-1878)[3], conte del Pinar, scrive: «la sedicente Prammatica Sanzione di Ferdinando VII non è altro che un intreccio di menzogne, menzogne che a questo povero Monarca di triste memoria fecero dire i suoi ministri.
Ferdinando offende la verità, la quale nessuno più di un Monarca è tenuto a rispettare, soprattutto nelle sue leggi, e ancor di più quelle leggi che riguardano gli interessi più importanti e più sacri del suo popolo»[4].
Nel 1832, trovandosi il re gravemente ammalato nel palazzo di La Granja, i sostenitori dell'infante tentarono invano di fargli fare testamento in favore di Carlo. Fallendo nell'intento, Carlo si trasferì in Portogallo. Intanto, Maria Cristina, nominata reggente durante la grave malattia del re (l'erede Isabella aveva solo tre anni), cominciò un avvicinamento verso i liberali e concesse ampie amnistie ai liberali in esilio, prefigurando un cambio politico verso il liberalismo che si sarebbe prodotto dopo la morte del re. Ferdinando morì nel 1833. L'infante Carlo Maria Isidoro, insieme con altri suoi sostenitori che lo consideravano il legittimo in quanto fratello del re, e non Isabella, si sollevarono e cominciarono la prima guerra carlista. Con questo fece la sua comparsa il carlismo.
Ultimi anni e morte modifica
Si indica con "Decennio nefasto spagnolo" l'ultimo decennio del regno (1823-1833), durante il quale venne attuata una durissima repressione nei confronti dei liberali, accompagnata da una nuova chiusura dei periodici e delle università, nello stesso tempo si registrarono sommosse ultra-assolutiste istigate dal clero e per i sostenitori dell'infante Carlo Maria Isidoro, fratello minore di Ferdinando, che si profilava quale suo successore. È in questo periodo che si consumò la scomparsa dell'impero spagnolo. La maggior parte delle colonie americane (fatta eccezione di Cuba, Porto Rico e Santo Domingo) trovarono l'indipendenza. Solo le Isole Caraibiche, insieme con le Filippine, le Marianne e le Isole Caroline, nell'Oceano Pacifico, rimasero sotto il dominio spagnolo.
Discendenza modifica
Il re Ferdinando ebbe 4 figli, tutte femmine, ma solo le ultime due gli sopravvissero:
Da Maria Isabella di Braganza:
- Infanta Maria Luisa Isabella (21 agosto 1817 - 21 gennaio 1818)
- Infanta Maria Luisa Isabella (nata morta il 26 dicembre 1818)
Da Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie:
- Infanta Isabella, che successe al padre nella titolarità del regno con il nome di Isabella II di Spagna, regnando dalla morte di quest'ultimo fino al 1868, quando dovette andare in esilio; sposò Francesco d'Assisi di Borbone-Spagna, ebbe figli;
- Infanta Maria Luisa Ferdinanda di Borbone-Spagna, andata sposa ad Antonio d'Orléans, duca di Montpensier, Infante (1859), ebbe figli;
Ascendenza modifica
Onorificenze modifica
Onorificenze spagnole modifica
Onorificenze straniere modifica
Nella cultura di massa modifica
Cinema modifica
- Napoléon (2002), interpretato da Alain Flick.
Note modifica
- ^ "Cerimoniale del battesimo del Serenissimo Signor Infante Don Ferdinando". Memorial literario instructivo y curioso de la Corte de Madrid, volume III, p. 82. Imprenta Real, Madrid, novembre 1784.
- ^ https://www.visitleon.info/unan-leon.html
- ^ Luis de Mon y Velasco, Bio-bibliografia, su edizionisolfanelli.it.
- ^ Luis de Mon y Velasco, Il diritto di Carlo VII al Trono di Spagna, a cura di Riccardo Pasqualin, collana Collana di Studi Carlisti, vol. 13, Chieti, Solfanelli, 2023 [1873], p. 168.
Bibliografia modifica
- Juan Arzadun, Fernando VII y su tiempo, Madrid, 1942.
- Luis de Mon y Velasco, Il diritto di Carlo VII al Trono di Spagna, a cura di Riccardo Pasqualin, Chieti, 2023.
Altri progetti modifica
- Wikisource contiene una pagina dedicata a Ferdinando VII di Spagna
- Wikiquote contiene citazioni di o su Ferdinando VII di Spagna
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ferdinando VII di Spagna
Collegamenti esterni modifica
- Ferdinando VII Re di Spagna, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.
- Ferdinando VII, su sapere.it, De Agostini.
- (EN) Ferdinand VII, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (ES) Ferdinando VII di Spagna, in Diccionario biográfico español, Real Academia de la Historia.
- (EN) Opere di Ferdinando VII di Spagna / Ferdinando VII di Spagna (altra versione), su Open Library, Internet Archive.
- (EN) Ferdinando VII di Spagna, su Goodreads.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 286447916 · ISNI (EN) 0000 0003 9238 1965 · SBN LIAV156708 · BAV 495/112311 · CERL cnp01007549 · Europeana agent/base/146733 · ULAN (EN) 500122384 · LCCN (EN) n80040243 · GND (DE) 119307421 · BNE (ES) XX1724030 (data) · BNF (FR) cb12699052r (data) · J9U (EN, HE) 987007261018805171 · WorldCat Identities (EN) lccn-n80040243 |
|---|